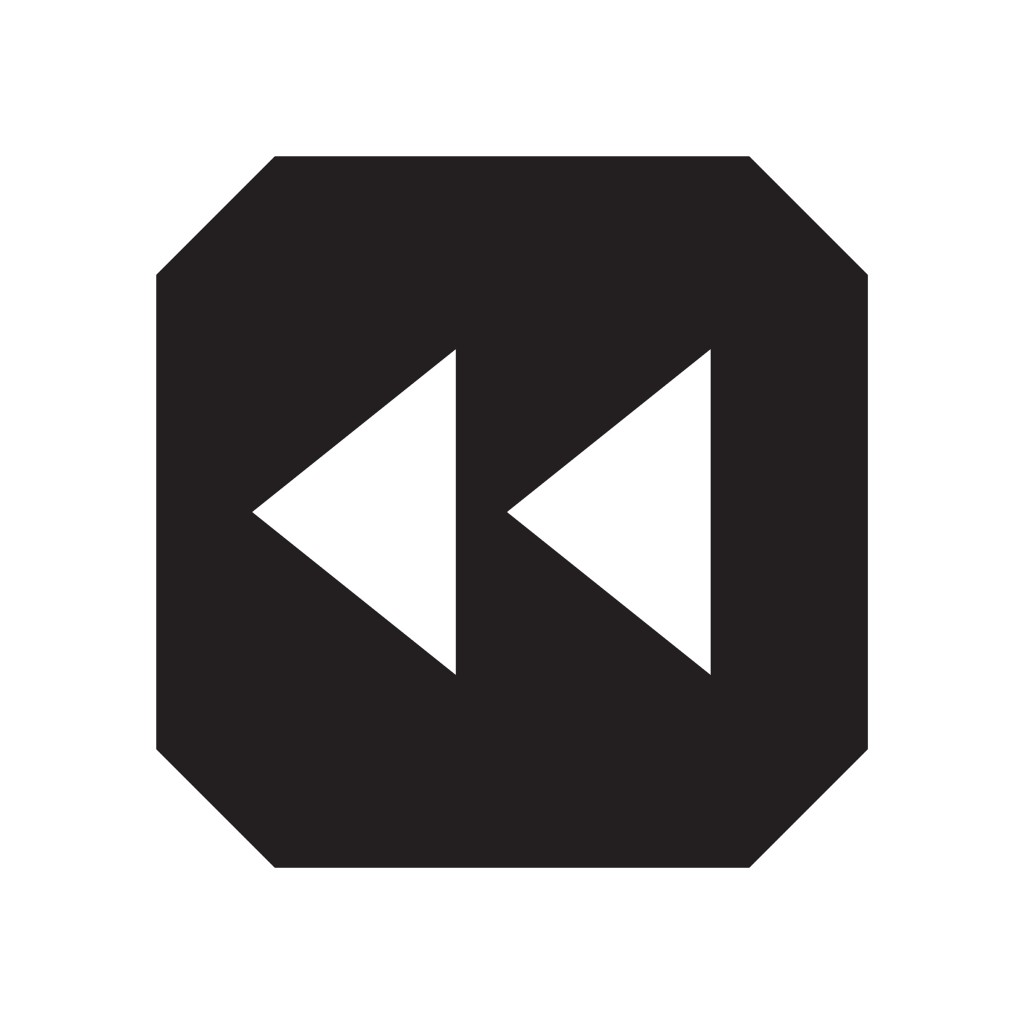Rewind
Mag 04
L'alba sul G.R.A., Racconti canne, caponord, centrale di Chernobil, Chernobil, disastro di Chernobil, droga, estate in sicilia, fumo, good bye Lenin, gra, grande raccordo anulare, guidonia, l'alba sul gra, massimo soldini, morte di un padre, nirvana, occupazione scuola, rewind, ricordi, roma anni 80, sentirsi da solo, sigarette, sogni bagnati, tufello No Comments
Questo post è stato letto 1356 volte!
Fa freddo e mia madre mi allaccia i pendagli del cappuccio della mia giacca a vento blu. Sento la gola costretta e sono serio, davanti l’ingresso di scuola. Un fotografo fa foto lì fuori e mia madre mi sistema i capelli..
Ho gli occhi grandi e neri, fissi ed un po’ inespressivi. Stringo i denti senza motivo, penso più di quello che dico e mi sento più grande e più solo, senza capire se il problema è non sapermi spiegare oppure non essere compreso.
Poi vado in bici con un maglione ridicolo e sgargiante, c’è il prato grande, davanti a casa, Roma anni 80 e le Vespe modificate, e c’è mio padre che mi da uno schiaffo, senza motivo, perché possa ricordare quel giorno, un evento. Uno schiaffo senza motivo così da cementare un giorno, un accadimento. Che usanza brutale, eppure efficace. Si vede anche nei film, nel Marchese del Grillo.
Metto in moto la vespa, è la mia priva volta, mi prendono in giro perché pensano non ce la possa fare, ma io sono già grande e pesto forte, il motore scoppietta e prendo il via, felice e sicuro: ce l’ho fatta e sarò accettato nel gruppo dei grandi.
E’ pomeriggio, sono con mio padre ed ascolto in silenzio i discorsi lì alla piccola bottega sulla piazza, dal meccanico dove fra olio e motori rabberciati scorre la vita semplice del dopo lavoro, delle mezze giornate di permesso, della scuola che va finendo e dei glicini di Monte Sacro che fioriscono e colorano le strade attorno casa.
E’ già caldo, forse maggio oppure giugno e mia madre urla dalla finestra del bagno perché torni a casa, la vedo dalla piazzetta, limite massimo di allontanamento, dallo spiraglio che i palazzi lasciano fin lì, un isolato più giù: l’unico spazio fra i palazzi: vedere casa da “così lontano” è la mia prima idea di viaggio, il primo senso di ritorno. Imbocco la discesa e faccio il rumore di una moto che sogno d’avere. Mia nonna cala un cestino di paglia dal suo balcone, dentro merenda ed acqua: viveri fra i 4 palazzi col cortile in mezzo, una miriade di bambini, storie, famiglie semplici e gente che parla da un balcone all’altro, donne dalle braccia grasse che si lamentano a prescindere.
Ci sono le mie sorelle, già grandi, universi distanti dal mio, i loro amici e quelle dinamiche troppo adulte per me, come i giornali porno che circolano in cortile o che sono nascosti giù al vecchio furgone abbandonato, al prato dove andavamo a nasconderci, per giocare ad allontanarci.
Già, “tu ci sei mai arrivato fino al fiume?”
No, mia madre non vuole e quindi…
E poi ci andavo lo stesso, per dimostrarmi che la strada di ritorno era lunga ma conosciuta, che potevo e sapevo farlo anche se il fiume era scuro ed incazzato e se sbucava fra le canne altissime dentro alle quali potevi sentirti perso parecchi minuti prima di sbucare col fiatone per la paura di prendere la via dell’acqua piuttosto che della strada sterrata.
Ed allora fumo, una Camel, e sento come un pugno ai polmoni: tosse e viso rosso ma la voglia di riprovarci anche se sono ancora alle elementari e se la “scuola” la sotto al cortile ed in casa mi fa più grande della mia età.
Il catechismo e le domenica mattina in chiesa a chiacchierare fra i banchi, ad essere rimproverati o premiati da Padre Mario suonando le campane dalle funi così grosse, grosse da poterle tirare per poi sentirti trascinato in su e ridere forte, offuscato dal rumore della campane stesse.
Il ritiro per la prima comunione, Gianvincenzo, Silvia, Letizia e le nostre storie che cambiano e si separano, la scuola che finisce e le corse a perdere il fiato lì alle case davanti alla scuola, nei giardini per far sgolare mamme e sorelle che aspettano.
I drogati fra le auto, le siringhe: “state attenti, non arrivate giù al Tufello, me raccomanno”.
Così arriva mio padre, mentre gioco in cortile, è metà giornata ed è strano e frettoloso, non è mai tornato a quest’ora: ha con se casse di acqua minerale, acqua in bottiglia che non abbiamo mai bevuto, latte a lunga conservazione e mi dice di guardare la tv, di cercare di capire e di portare tutto su a casa, che mi spiegherà tutto al ritorno, che deve tornare al lavoro perché stanno facendo i turni per andare a casa. E’ esplosa la centrale di Chernobil e la nube tossica se ne va in giro, ci spiegheranno a scuola, in maniera pericolosa: anni dopo capiremo che quella corsa ai supermarket sarebbe stata comunque inutile e che per “fortuna” la nube è rimasta circoscritta anche se ha ucciso gente come noi, semplice come noi, padri e figli, genitori che correvano al supermarket per far scorte come mio padre aveva fatto. Eravamo solo più lontani e ci ripenserò più di 20 anni dopo, senza un vero nesso, guardando quel meraviglioso film, Good bye Lenin.
Arrivano tutte le mie estati in Sicilia, dove i miei mi mandavano per farmi star meglio ed evitare i giorni a Roma, da solo, con gli amici già partiti. L’incubo ed il disagio, “si che sto bene” e poi non era vero. “Ma ti diverti?” “Si mà”. Tutto detto al telefono, tutto trattenuto, tutto segreto, fino ad oggi. Ma poi questo un altro capitolo di anni spesi a dire e non dire, di anni che non saprò mai scrivere ma che ho saputo finalmente raccontare, anche se non qui, se non a tutti.
Pare solo un attimo e sono a Guidonia, alla scuole medie e Roma è un ricordo per me dolce, per le mie sorelle rabbioso perché private di una quotidianità più radicata e consapevole della mia, spezzata un po sul nascere dal progetto di vita tranquilla qui in campagna, alla casa costruita con anni di sacrifici.
Sullo scuolabus, poi a pallacanestro, di notte a scrivere, ad ascoltare musica e vedere tv, a leggere libri, enciclopedie, murato in camera per scelta, un po’ distante da tutto. Lontano dai pomeriggi di adolescenza che i miei compagni vivevano sereni. E non riuscivo ad invidiarli, perché i miei pomeriggi di anni prima, nei cortili a Roma erano di più di quelli che stavo perdendo, perché mi sentivo presuntuosamente più grande e di aver giù vissuto più di quanto loro andavano dicendo. Continuavo a credere non avrebbero potuto capire. Ed oggi, lo credo ancora.
Ed il nastro accelera e mi riporta a Roma, ai pomeriggi senza far nulla, passati in metro da capolinea a capolinea, a studiare e cazzeggiare, ai giri col motorino degli amici, alle scuole superiori, ai sogni sempre più bagnati, alle occupazioni, alla politica a scuola, ai pomeriggi e le sere nelle aule occupate, tante sigarette, quella sensazione di allargare, capire e conoscere ed abbracciare la vita vera incrociando le altre scuole, mescolando persone, storie, ed amicizie che parevano perfette e che poi sparivano dopo qualche giorno vissuto così intensamente, lasciandoti indietro deluso, frustrato, svuotato e fintamente pronto alla vita che sarebbe arrivata e che sarebbe stata più cattiva e tagliente di quanto allora avresti potuto temere.
Il nastro salta e sono ai campionati di basket che contano qualcosa di più, alla musica dei Nirvana nelle orecchie, alla rabbia inespressa, all’inquietudine, alla mia barba spuntata da tempo e lasciata crescere per sembrare più grande e fare il filo alle tipe della scuola difronte.
Il fantacalcio, i soldi rimediati, la paga settimanale della mamma, i lavori di straforo, il diario da scrivere, i biglietti da scrivere per gli amici, i temi per i professori: e scrivere è quasi un piccolo lavoro oltre che una scoperta soddisfazione. “Che me scrivi pe la ragazza mia?”. E poi coi soldi sigarette e scommesse clandestine sul calcio sperando di svoltare, di vincere cifre che poi non mi avrebbero mai pagato perché troppo alte, cifre che non mi avrebbero portato più in la che in sala gioco o in una pizzeria, a sognare il lavoro, un’indipendenza che ancora oggi non ho avuto del tutto.
Avanti e poi indietro, il nastro non ha governo e mentre sonnecchio sul letto salto parti bellissime ed importanti, ma non per scelta, ma come se poi ne fossi più geloso, se avessi premura e voglia di raccontarle con più spazio che già so di non avere o di non voler occupare, almeno stanotte.
E così sono militare e viaggio finalmente sui treni come avevo sperato leggendo sui libri e scrivo ancora, invento e scopro che mi fa stare bene, scopro che a qualcuno piace ancora e che i qualcuno aumentano, aumentano così come la paura di fallire e di provarci davvero. E viaggio, torno e vado, e litigo con mio padre, poi trovo lavoro al cantiere ed ogni mattina mi piscio sotto dal freddo perché non ci sono porte e finestre, perché sono le 7 di mattina e sono già al lavoro, perché sento le mani spaccate, le speranze deluse ed il diploma sbagliato. Poi svolto e trovo lavoro, per un concorso di cui a qualcuno ho già raccontato, e lo trovo fra fortuna ed impegno, fame e bisogno: penso che ce l’ho fatta e per un po funziona pure.
In mezzo c’è tanto, ci sono luoghi, persone, viaggi, il primo stipendio, quella rivalsa dal giornalaio, comprando una scatola intera di pacchetti di figurine dei calciatori: vaffanculo, finalmente posso, finalmente non devo chiedere, finalmente mio padre non dovrà inventare una scusa per non vergognarsi di qualcosa che capirò anni dopo, sarebbe stato invece qualcosa di cui invece andar fiero.
E compro scatole di figurine senza attaccarle, per rivalsa, per rabbia, anche se ormai dicono che sono adulto. Ma anche questa è una storia, un capitolo da spiegare che meriterebbe più spazio e che stanotte annoierebbe più del resto.
Scivola il nastro e mio padre è già morto. E’ il giorno del suo funerale e non mi sembra più lui. Ha un’espressione svuotata e mi sento distaccato, meglio dei giorni prima, di quando era malato e sofferente, di quando ero impotente e soffrivo per non poter aiutare quel Gigante che tante volte aveva aiutato me. Sto meglio di quelle notti non dormite lì in ospedale, spese a guardare fuori dalla finestra, nel buio della città in silenzio, ma mi sento solo e non so a chi dirlo e come dirlo, a chi spiegarlo a chi gridarlo. E sono olio nell’acqua, sempre.
E mio padre sembra indifeso, vestito e perfetto come ha sempre voluto, ha un aspetto perfetto ma non è già più lui. E’ sereno ma per me è una maschera, una rappresentazione di se. E’ quella mattina, la mattina del funerale e parlo con i parenti di un altro defunto e gli racconto parti della mia vita, distaccandomi dai miei parenti, da quella scatola di mio padre che ormai non c’è più. E’ lì che il vuoto mi ingoia, che capisco che sono al muro e che vorrei andare, che “lontano” sarà fra le parole più ricorrenti.
E mi sento perso e piango ancora, come ora, e non lo dico ne lo do a vedere. Ed organizzo una festa al contrario per mio padre, sostengo mia madre guido forte sul Gra di Roma, buco una notte, canto una canzone, lacrimo caldo sulle mie guance e poi guido lento ed arriva l‘Alba sul Gra e quell’idea della raccolta di racconti che poi non avrò mai il coraggio di pubblicare.
Faccio uscire tutti, scucio il taschino delle giacca di mio padre e lo guardo non reagire, scostarsi come avrebbe fatto se fosse stato davvero lui, se fosse stato vivo. No, non è più lui e fa meno male e fa meno effetto e sono più forte e solo, solo come non ero mai stato. E parecchi si affidano e prendono consigli invece che darli: penso che la vita non va avanti, che sterza di brutto e diventa un’altra. E’ così, lo penso tuttora.
Mia madre gli mette nel taschino dei soldi, una foto di loro due da giovani. Io gli lascerò il fazzoletto portafortuna che portavo sotto la sella di ogni moto, per tornare da ogni viaggio: stavolta, il viaggio più lungo tocca a lui e mi sembra giusto così anche se poi prevale il disarmo per un gesto inutile ma simbolico e finisco per aver paura di sfiorarlo e non sentire il suo odore, il suo calore e la sua pelle ruvida e nervosa.
Capisco che ho lasciato che mio padre morisse senza averlo mai abbracciato. Ma ora è troppo tardi e la macchina del tempo sta solo in quel film. Lo dirò ai miei giocatori, anni dopo, nel discorso pre partita di una gara giocata il 19 marzo, festa del papà. Gli abbracci mai dati, quelli spezzati, i baci non dati e tutti quelli dato, che ora non avresti mai voluto dare, come per preservarti: ma l’ho capito solo “oggi” e quella macchina del tempo, no , non ce l’ho ancora.
Allora parto, vado a Caponord con un bagaglio di rabbia. E guido forte, buco temporali e freddo, devio buche, salgo montagne, scendo sul mare, 7 giorni e sono lassù. Mastico il sale portato dal vento forte della Norvegia, arrivo lassù e piango forte, guardando dalla rupe, dall’ultima parte d’Europa prima del mare: e non ho il coraggio di lasciare lì, come mi ero ripromesso, la foto di mio padre in moto: e la porto ancora con me. E penso ancora quello: “lontano”, ma è il dove che non focalizzo ancora.
Torno a casa e metabolizzo, o almeno ci provo, incasello almeno una parte di quello che ho visto e vissuto, detto, trattenuto, mai raccontato, mai scritto.
Ma prima di questo ci sono i grandi viaggi, l’Asia. C’è quel pensare continuamente, alla fine di ogni ritorno: adesso ” E adesso dov’è che vado?” E mi sento perso e torno sul campo da basket, prima torno a giocare, per dimostrarmi che ci sono, poi alleno ed arrivo quasi ad oggi, a stasera.
E mi accorgo che ho tirato lungo e confuso tutto, scrivendo, che dovrei e vorrei cancellare, riordinare, rimediare, rifare, oppure scrivere per bene e più a lungo: organizzare.
Sonnecchio sul letto e la radio mormora ancora: il nastro del sogno correndo veloce ha saltato date e paesaggi, personaggi e viaggi, storie più e meno importanti, tappe incredibili e piccoli aneddoti che per alcuni sarebbero insulsi ma che per me poi sono il sapore del tempo.
E sono ancora in viaggio, e vado lontano.
Finalmente so dove.
Ed ho paura, e certe notti fa freddo, e certe mattine fanno male e sembrano solo una grossa pagina bianca.
Ti va se scriviamo insieme?
Questo post è stato letto 1356 volte!
 RSS
RSS